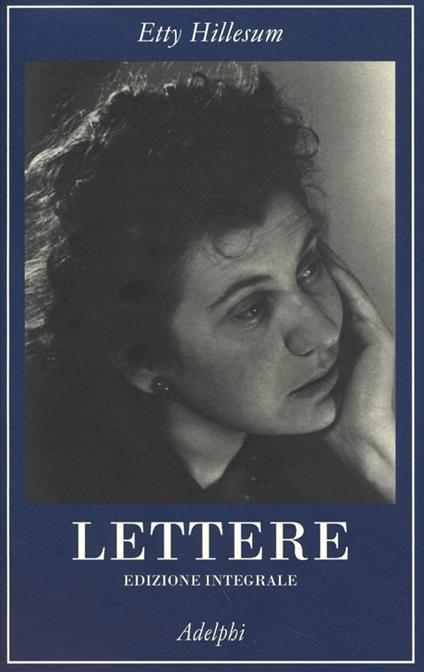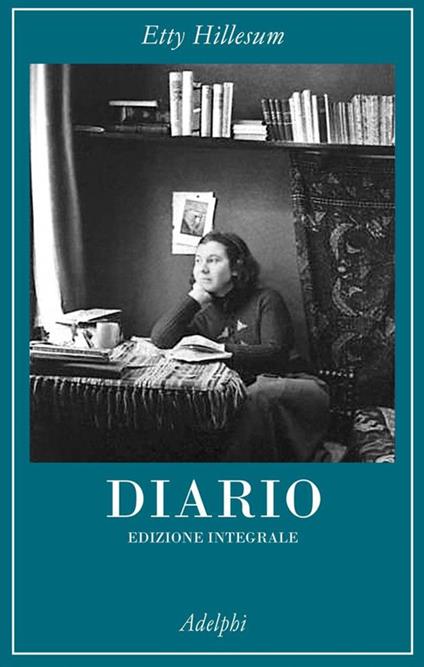E. HILLESUM, Lettere, ediz. integrale, Adelphi
“ “ Diario, ediz. integrale, Adelphi
Si vorrebbe essere un balsamo
per molte ferite.
Etty Hillesum
Etty Hillesum era una giovane ebrea olandese uccisa ad Auschwitz quando non
aveva ancora compiuto 30 anni. Perché parlarne oggi? Per diverse buone ragioni.
Intanto perché il diario e le lettere che ci ha lasciato (in Italia sono pubblicati
entrambi da Adelphi) costituiscono uno dei più alti ed emozionanti documenti
dell’espressione umana, testamento spirituale ed esistenziale di una donna di
raffinata cultura, inquieta, spregiudicata, modernissima nel suo essere donna.
Donna con una intensa vita amorosa e con «una forte inclinazione erotica» e
sessuale senza sensi di colpa o di peccato («il mio amante non mi ha forse
sgombrato la strada che conduce direttamente a Dio, dopo avermela aperta con le
sue imperfette mani umane?») e una altrettanto intensa vita interiore e spirituale.
Ma anche donna assolutamente, ‘scandalosamente’ normale che si è trovata a
dover affrontare l’orrore della Shoah e che ha testimoniato in prima persona, fino
al prezzo della vita, l’amore per gli altri (anche per i nazisti assassini) e il dovere di
estirpare il male dentro di noi come alternativa all’odio per i nemici («Non credo
che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver fatto la nostra parte
dentro di noi. È l’unica lezione della guerra: dobbiamo cercare in noi stessi, non
altrove»).
Etty era in grande anticipo sui suoi tempi – e non solo per lo stile di vita: le
piaceva molto fumare, o per certi suoi stati psicologici a noi oggi così familiari
come la depressione o i disturbi psicosomatici -, ma anche per esempio per il
modo aperto e seduttivo con cui si poneva in relazione con il maschio, quando le
apparisse interessante («Sono presuntuosa a dire che possiedo troppo amore per
darlo a una persona sola? Non credo di essere adatta a un uomo solo… non potrei
neppure essergli fedele, non per via di altri uomini, ma perché sono composta di
tante persone insieme… E il mio cuore è grande abbastanza per contenere due
amori»).
Ma vale la pena di incontrare la Hillesum anche per la capacità che ha avuto,
pur così giovane e così innamorata della vita, di porsi domande decisive e
inquietanti riuscendo a darsi risposte chiare e dolorose alle quali tenne fede con
coerenza e che la portarono ad Auschwitz. E poi perché la sua fede ha quel respiro
universale così moderno non dipendendo dall’adesione totalizzante a nessuna
Chiesa. E ancora perché Etty ci ripropone con forza e ostinazione virtù oggi
passate di moda: l’indignazione (invece dell’odio) che è la virtù di chi non vuol
abituarsi all’ingiustizia, né diventare vittima dell’indifferenza e dell’impotenza; il
silenzio e la semplicità (quest’ultima «una delle più grandi e difficili capacità dello
spirito» secondo Dietrich Bonhöffer, il teologo protestante fatto impiccare da
Hitler a Flossenbürg due giorni prima dell’arrivo dell’Armata Rossa); e da ultimo
la compassione, intesa nel senso etimologico del termine: cum pati, soffrire
insieme, saper accettare su di sé il dolore del mondo, quel dolore che alcuni
vogliono rimuovere, altri non riescono a sopportare, altri ancora non vogliono
neppure vedere. Mentre invece, oggi come ieri, bisogna avere il coraggio «di
guardare in faccia ogni dolore».
Non ci farebbe male in tempi come questi incontrare (o ri-incontrare) Etty
Hillesum. La sua vita, i suoi pensieri, le sue riflessioni, quasi sempre di
straordinaria modernità e attualità possono essere ancora oggi un «balsamo per
molte ferite», un abisso di profondità capace di dare le vertigini a chiunque vi si
avvicini, credente o non credente. Chiunque legga il suo diario e le sue lettere ne
resta indelebilmente segnato. Attenzione però: confrontarsi con lei non è facile;
bisogna avere il coraggio di guardare con spietata sincerità dentro sé stessi…
Per oltre un anno, dall’agosto ’42 al settembre ’43, Etty visse e lavorò nel campo
olandese di smistamento di Westerbork, ultima sosta prima di Auschwitz. Lì trovò
Dio, lì trovò gli altri. Fu «il cuore pensante della baracca e del campo» e lì,
assistendo vecchi e bambini prima della loro partenza verso l’orrore, si convince
«che dalla vita si possa ricavare qualcosa di positivo in ogni circostanza, ma che si
abbia il diritto di affermarlo solo se personalmente non si sfugge alle circostanze
peggiori». Avrebbe potuto salvarsi, ma volle condividere il destino del suo popolo.
Sì, sapeva o aveva intuito che cosa li aspettava a est («Vogliono il nostro
annientamento; non possiamo più farci alcuna illusione al riguardo»), ma
«chiunque voglia salvarsi sa che se non ci va lui, qualcun altro dovrà andare al suo
posto… è un destino di massa che si deve imparare a sopportare con gli altri».
Etty era convinta che «se salveremo i nostri corpi e basta, sarà troppo poco.
Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si
conserva… Se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient’altro
che i nostri corpi salvati a ogni costo [ricordate il Primo Levi di I sommersi e i
salvati?] — e non un nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della
nostra miseria e disperazione — allora non basterà».
«Quando dovrò partire — scrive nel diario — porterò tutto dentro di me perché si
deve essere capaci di vivere senza libri [nello zainetto che s’era portata a
Westerbork aveva l’amato Rilke del Libro d’ore e la Bibbia] e senza niente.
Esisterà pur sempre un pezzetto di cielo da poter guardare e abbastanza spazio
dentro di me per congiungere le mani in una preghiera. So che seguirà un periodo
di umanesimo e l’unico modo che abbiamo di preparare questi tempi nuovi è di
farlo fin d’ora in noi stessi… Vorrei tanto vivere per aiutare a trovare questi tempi
nuovi: verranno di certo, sento che stanno crescendo dentro di me. Ma se tutto
questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci
dalle piccolezze e dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile».
Etty ha il coraggio di guardare in faccia ogni dolore, ma non odia gli aguzzini
suoi e del suo popolo e questo è un altro grande insegnamento che ci lascia: infatti
è facile e al limite rassicurante pensare che tutto il male o il peggio sta fuori di noi,
negli altri; molto più inquietante pensarlo dentro noi stessi come ha fatto lei. «Si
deve accettare la morte, anche quella più atroce, come parte della vita… Io sono
quotidianamente in Polonia… sono accanto agli affamati, ai maltrattati e ai
moribondi, ogni giorno — ma sono anche vicina al gelsomino e a quel pezzo di
cielo dietro la mia finestra o ai lupini viola della brughiera dietro il reticolato: in
una vita c’è posto per tutto. Per una fede in Dio e per una misera fine… Ho amato
tanto la vita quand’ero seduta alla mia scrivania circondata dai miei scrittori, dai
miei poeti e dai miei fiori. E là nel fango e tra le baracche popolate da uomini
scacciati e perseguitati, ho trovato conferma di questo amore».
«Abbiamo lasciato il campo cantando…»: sono le ultime parole che Etty ci ha
lasciato, scritte su una cartolina postale fatta scivolare sui binari da un pertugio del
vagone piombato numero 12 che la stava portando verso l’orrore di Auschwitz, là
dove risuonava il «latrato del disumano».